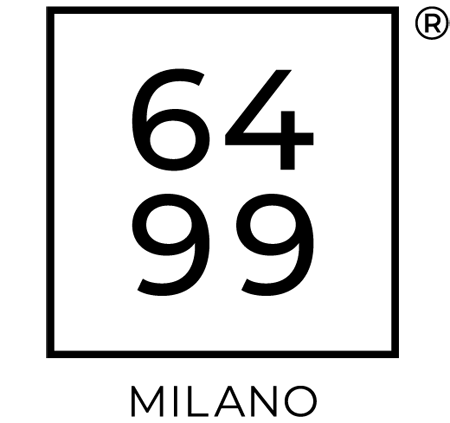Mi tocca fare l’elogio di un grande amico, di un grande pittore, che ho conosciuto nei lontani anni Ottanta grazie alla presentazione di Tommaso Trini a Milano, dove si era da tempo trasferito dalla sua nativa Catania, città in cui io allora abitavo. Milano era il suo luogo giusto, quello che poteva accudire la sua sacerdotalità, molto più che una vocazione, per la pittura intesa come esplicazione di un alto senso della cromaticità, della dissolvenza, della frammentazione. La sua era una sperimentazione sull’identico, chiamato a risolvere le infinite possibilità di sfumature del significante, come teatro della visibilità, quindi dell’essere e dell’apparire. Una perseveranza mai intaccata dalle tante sollecitazioni del momento a tentare “altro”, poiché per lui il mistero del colore rimaneva centrale: un colore che nel reale non esiste, ma che viene creato nella mente. Lo stesso concetto che aveva portato Leonardo, facitore per eccellenza di ogni materialità, ad affermare che la pittura è cosa mentale—un pensiero che sembra cucito su misura per Pino Pinelli. La sua cromaticità è sempre densa e piena, dotata di una forza immaginaria intrinseca, che non si piega davanti alle difficoltà modulatrici e conserva una leggerezza imprendibile. La chiamava “pittura pittura”, con un senso rafforzativo, non minimale, mai disdegnante sentimenti, emozioni, fascinazioni, risolti sempre sul piano della tattilità e della plasticità scultorea, in cui il senso del rilievo diventa un’evocazione spaziale totalitaria, capace di avvolgere lo spettatore e condurlo in un rapimento poetico della pura visibilità.


Mi sono sempre chiesto se la sua fosse una linea analitica o sintetica nella verifica della qualità dei colori e della forma, nel modo in cui questi si fondevano insieme, proprio nel momento in cui venivano “incisi” in una disseminazione architetturale, a volte geometrizzante, a volte baroccheggiante, ma sempre spettacolare. Già, perché lui non abbandona mai il crinale tra contemplazione ed emozione, sorprendendole entrambe e facendo del loro significato rarefatto un’attrazione di meraviglia e suadenza. Le sue doti, proprie e intrinseche, sono state accentuate dalla prossimità di Mario Nigro, Enrico Castellani, Agostino Bonalumi e Turi Simeti, con cui ha condiviso una serie di fluidità caratterizzate dalla forza della minimalità, dal non concedere nulla al decorativismo. E questo è certamente un lascito importante del Novecento più impegnato nella lettura creativa, non dogmatica e ripetitiva, delle avanguardie, senza eclatanze né forzature, evocando un silenzio che, per quanto mi riguarda, ancora mi accompagna. Ogni volta che volgo lo sguardo sui due suoi lasciti che conservo nelle mie case romane e palermitane, provo una compagnia speciale dello sguardo, che induce alla rêverie, con gli occhi ben aperti, lasciandomi illuminare dal quid speciale che lui ci metteva dentro: la luce.
KLESSIDRA | A CURA DI FRANCESCO GALLO MAZZEO