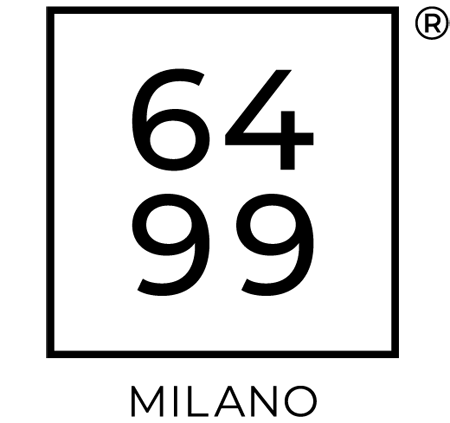La sua la possiamo considerare una trasmutazione, una translitterazione immaginaria, fatta da un moderno che non copia, non si identifica, non regredisce, ma compie un fantasioso (filologico e innovatore) viaggio all’indietro, fino a un certo Rinascimento, o meglio a un certo Manierismo, scelto come punto di forza per un dialogo contemporaneo, come avviene quando si stabilisce un’affinità elettiva che non è diacronica, ma acronica, come un innamoramento, un’intuizione che comprende la razionalità, ma la coniuga con l’emozione, nell’alto senso di comprenderne i tratti di una attualizzazione confidenziale ma, nello stesso momento, di misura, di forma, di tecnica, di stilistica. La poetica di Riccardo Lumaca fa sintesi, dinamica, del concettuale e del gestuale, nella forma di una tradizione del nuovo, che interpreta i due termini di tradizione e di nuovo come di una conspiratio che non è solo possibile, ma “necessaria”, in una concezione continua/discontinua, verso il futuro, eretica nei confronti delle avanguardie storiche, portandosi dietro, davanti e tutt’intorno la ricchezza della storia, ma senza alcun dogma storicista di determinismo e ripetizione, bensì come strutturazione mentale, di tipo leonardesco, di un invisibile che è in mezzo a noi, non come fantasma disturbatore e inquietante, ma, piuttosto, come “ramo d’oro” dell’intelligere.


La tradizione manierista appare nella sua pittura come una grande riserva di stimoli sensibili e intuizioni mentali, ad una ricerca che ad ogni punto non vada a capo e cominci da zero, come in Marinetti, Tzara soprattutto, ma come un continuo apparire di albe e tramonti, dove il simile non è identico, ma è ricchezza di un alfabeto, di un codice visibile e invisibile, che è soprattutto atmosfera, quindi vita. Il nuovo, per lui, non è un altro da sé: appartiene allo scorrere del tempo, che non è solo cronos, ma soprattutto bios, emos, poiesis, intellectus, in una dialettica di immagini in cui il passato torna sotto forme a estasi sincronica, come contemporaneità che è affinità elettiva, nobiltà d’animo e non (come tanti erroneamente credono) la parte più vicina a noi della modernità. Un nodo di essere nella discontinuità, senza sacrificare le genealogie: era il suo mantra, la sua ragione d’essere, come venne compresa da Carmine Benincasa e Cleto Polcina, che me lo fecero conoscere, nella sua umanità tanto discreta quanto forte e prorompente. Da allora — erano gli ormai geologici anni Ottanta — ci siamo accompagnati per tutto il tempo della sua vita terrena. Lui è sempre con me, nella forma degli scritti che gli ho dedicato e nell’immagine plurale di due opere fotografiche che stanno nella mia casa romana. Di lui si è fatta una bella mostra, nella sua Parma: un evento fantastico, in cui emerge tutta la sua forza espressiva e la sua “taciturna” capacità di attraversare stili e poetiche, ogni volta trovando e ritrovandosi.
KLESSIDRA | A CURA DI FRANCESCO GALLO MAZZEO